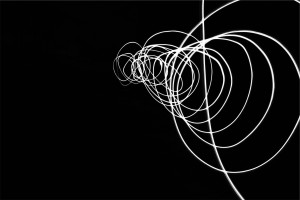RACCONTO QUINDI SONO, UMANO
![rtr2avwj.630x360[1]](http://www.paolarondini.it/wp-content/uploads/2016/08/rtr2avwj.630x3601-300x201.jpg)
Da piccola ascoltavo mia nonna Isolina nella sua epica di campagna, coi raccolti andati bene, quelli baciati da dio, e quelli maledetti dalla grandine, ed erano, di volta in volta, favole col premio di un ballo di fine estate nell’aia illuminata a festa, o horror col cattivo padrone che si staglia nero e arcigno sulla soglia della porta.
E le parole, nel dialetto composto e delicato di mia nonna, erano un’antica e potente tecnologia di realtà virtuale, capace di innescare una sequenza perfetta di immagini, e capitoli di una storia che poteva, doveva continuare.
Una storia che parte da lontano: un gruppo di primitivi, mal illuminati dalla luce di un fuoco o sotto l’alone lattiginoso della Luna, mugugnano terribili e ingigantiti resoconti di caccia, quelli che, da che mondo è mondo, fanno addormentare i bambini.
E, da quel momento, noi umani, in forme sempre più attente e desiderose di durare, non abbiamo più smesso, di raccontare.
Perché raccontare é una delle più peculiari caratteristiche dell’essere umano. Raccontare, oltre che creare empatia e generare immedesimazione, pone la nostra mente di fronte a situazioni inedite, soluzioni e simulazioni sui grandi dilemmi della vita.
Quando raccontiamo facciamo pratica, come dice bene J.Gottschall nel suo bel testo “L’istinto di narrare”, con le sfide che verranno, esterne, le più disparate, o interiori, d’anima, sfide che sono sempre state le più cruciali per il nostro successo come specie.
Negli anni in cui ci si interroga se scrivere e pubblicare un romanzo abbia ancora senso, ora che tutto sembra generato solo da immagini fulminee e piatte, che spesso sentenziano, scioccano, ma non raccontano quello che c’è stato prima, o immaginano ciò sarà dopo, la risposta potrebbe invece essere molto ottimista, laddove si dia credito alla funzione del romanzo come visione periscopica, come detonazione di fantasia, generatrice di nuove visioni e nuovi pensieri
Ecco perché raccontare storie non può morire e non importa come si evolverà, il raccontare, attraverso quali strumenti, dentro quali nuovi canali espressivi; l’uomo, per rimanere tale, avrà sempre bisogno di intrecci tra ricordi e visioni, di costruzioni di vicende, di creazioni di altri uomini.
Per ritrovare noi stessi, in giorni di cupo cine reportage che alza la posta della nostra assuefazione alle immagini, basterà quindi, forse, perdersi di nuovo dentro le parole di un romanzo, e lasciare che siano loro, le parole, cercate, analizzate, ponderate, inventate, a creare nuove connessioni neurali grazie alla potenza sempre allerta della nostra immaginazione di lettori.